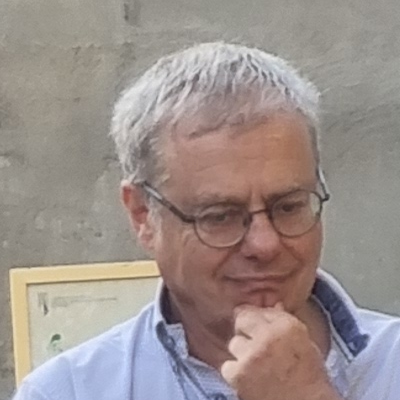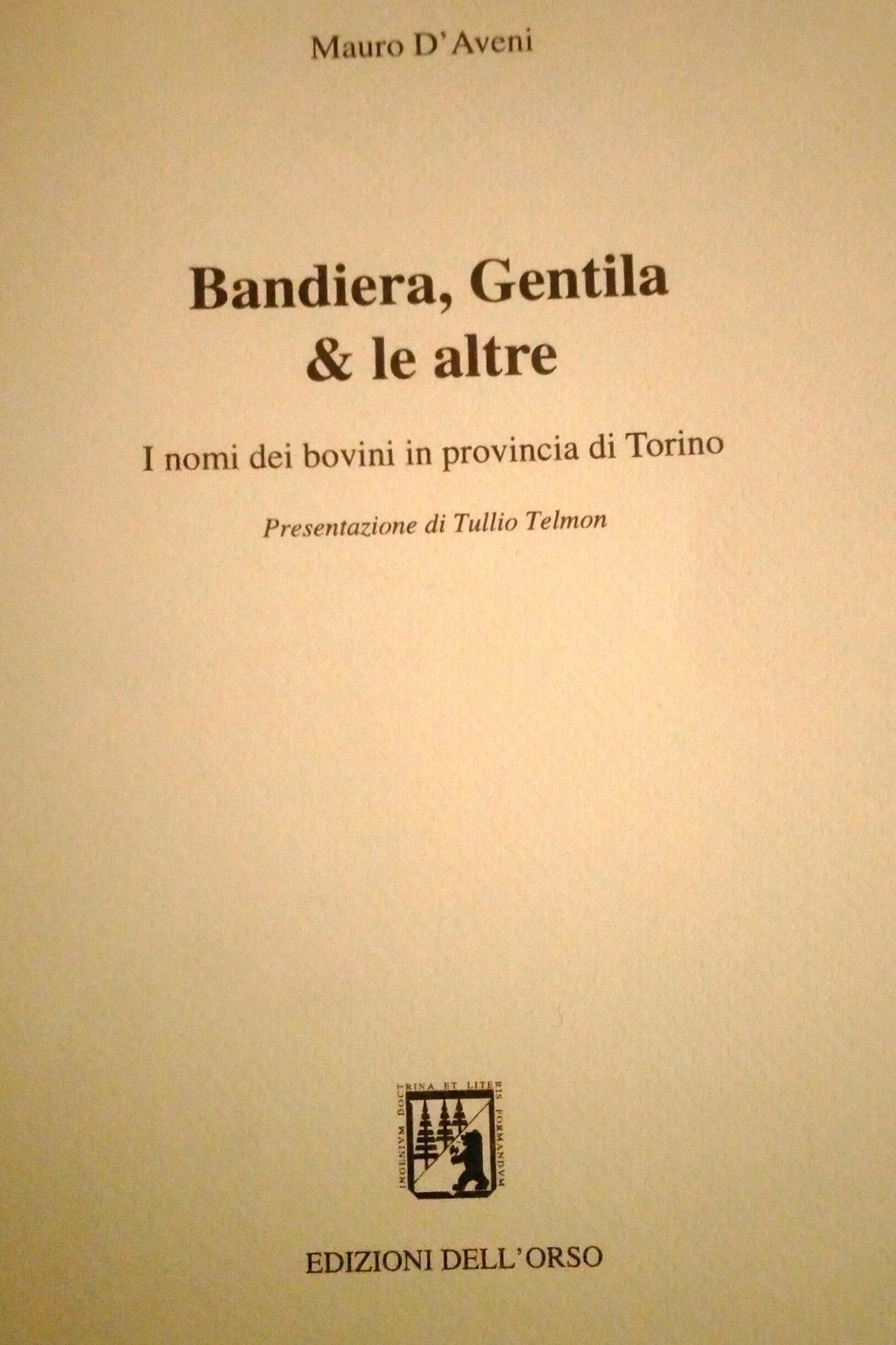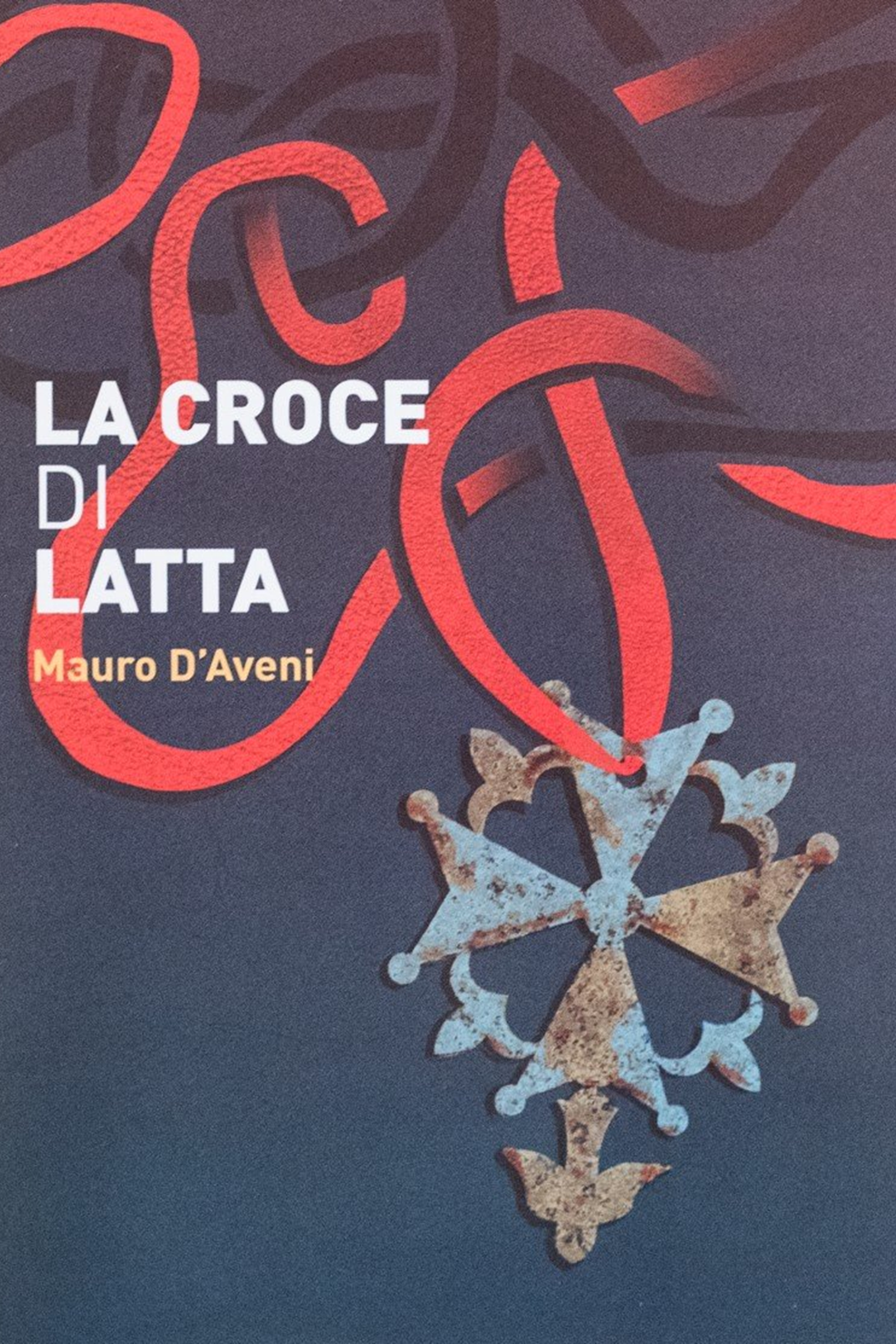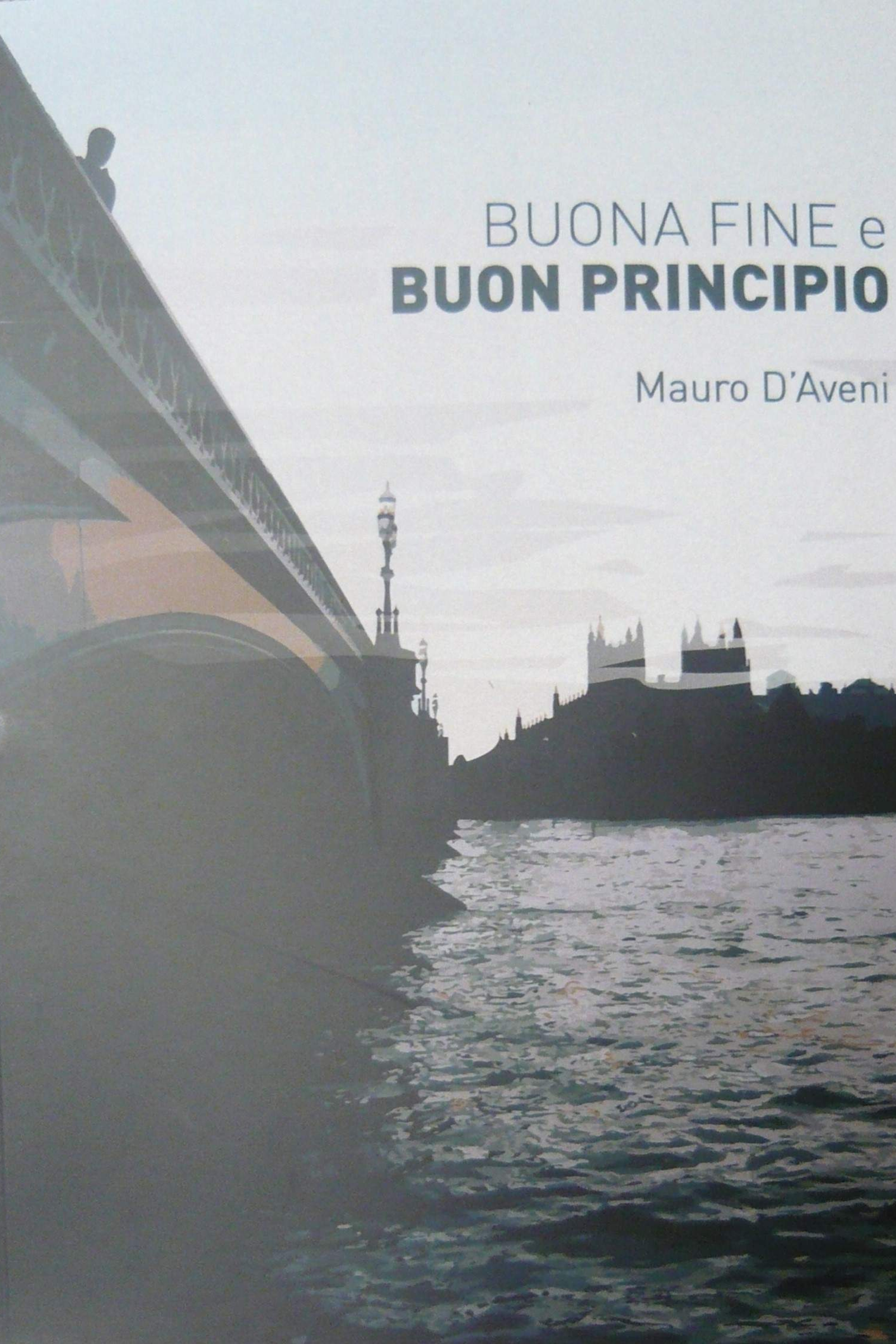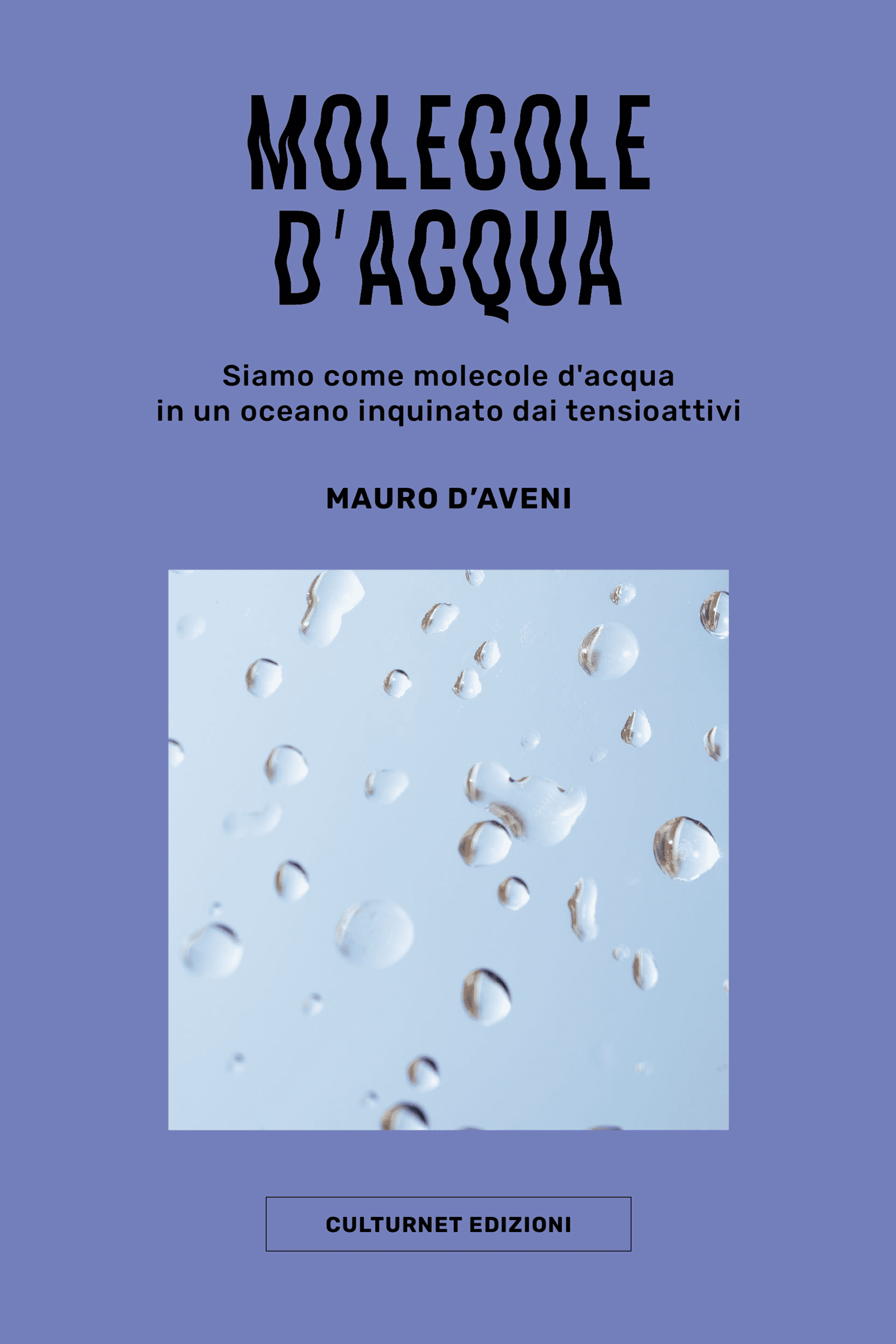Studio
Bandiera, Gentila & le altre
Questo studio sui boonimi, i nomi propri dei bovini, rappresenta una novità quasi assoluta nel panorama della linguistica italiana. In esso si propone, attraverso una classificazione per categorie strutturali e grammaticali e per aree semantiche del vario insieme dei materiali onomastici raccolti (1716 nomi diversi attribuiti a 5646 bovini), un utilizzo del nome come strumento d’indagine e scandaglio d’un “immaginario” sottostante, ben sapendo che il nome è tutt’altro che una vuota etichetta e rappresenta invece un potente indicatore culturale.
Quest’opera, che riesce a coniugare rigore scientifico e gradevolezza di lettura e si rivolge pertanto ad un pubblico più ampio di quello specialistico, tende ad evidenziare la complessità e la tipicità dell'”immaginario contadino” attuale e a far emergere le matrici sociali e culturali che lo sostanziano. Essa ambisce cioè riavvicinare al fascino attuale ed immutato d’un mondo in bilico fra tradizione e avvenirismo e render conto d’un immaginario che sarebbe tuttora il nostro se i nostri nonni non avessero abbandonato i campi per l’officina, i cascinali per la città. E che comunque, a ben vedere, rimane pur sempre profonda e imprescindibile parte di noi.
«Sapere il nome, dire la parola, è possedere l’essere o creare la cosa.
Qualunque animale viene domato da chi sa dargli il nome». (Granet, 1934,I,1)
PREMESSA all’edizione del 1994.
L’accostamento tra zootecnia e mondo agricolo da un lato, linguistica e scienze umane e sociali dall’altro, può apparire, a prima vista, indubbiamente anomalo ed a taluni persino azzardato.
In effetti linguistica e scienze sociali nel loro insieme raramente sono andate occupandosi del mondo contadino, se non per confinarlo in un’area apposita all’interno d’una qualche disciplina più generale (la sociologia rurale ad esempio) oppure più spesso per utilizzarlo come serbatoio di materiali etnografici ed etnolinguistici. Dal canto loro le scienze umane troppo sovente l’hanno rinchiuso in una dimensione bucolica, arcaica e arcadica, con un’inguaribile propensione a considerarlo, con immagine pasoliniana, lucciola morente.
E’ comunque costante – e così generalizzata da divenire luogo comune – una lettura, ora nostalgica ora sprezzante, totalmente inattuale del mondo agricolo, sempre inevitabilmente coniugato al passato. In realtà il contadino, venuto meno il contado, ha dovuto giocoforza trasformarsi – trasfigurarsi diremmo – in figura imprenditoriale, in uomo di mercato. E, come tutti i mutamenti, questo cambiar pelle non è stato certo indolore e neppure può dirsi totalmente compiuto.
Esiste poi nella società italiana un più generale atteggiamento di incomprensione, se non di vera e propria avversione, nei confronti del mondo agricolo, per lo più ignorato, qualunquisticamente considerato oasi di privilegi contributivi e fiscali, nonché periodicamente ritenuto responsabile dei più turpi misfatti ecologici. E’ questo un vezzo tipico dell’autolesionismo nostrano, poiché non trova riscontro nei paesi europei più avanzati, che, al contrario, considerano l’agricoltura settore di strategica importanza per la loro economia e per la loro stessa cultura.
Eppure – o forse freudianamente proprio per questo – nella memoria d’ogni italiano che abbia dai trentanni in sù vi è una stalla, un filare, un campo di grano. E invece persino linguisticamente si è consumata questa sorta di rimozione delle origini: chi ricorda ormai che vacca, ben prima che epiteto o imprecazione, è il vero nome della mucca? E del resto pure noi, sensibili alle sensibilità altrui, financo alle più distorte, ci uniformeremo, usando nel prosieguo della trattazione il più asettico bovina.
Fin troppo scoperta perciò appare l’ambizione di questo studio sull’onomastica bovina: riavvicinare al fascino attuale ed immutato d’un mondo in bilico fra tradizione ed avvenirismo, e render conto d’un immaginario che sarebbe tuttora il nostro se i nostri nonni non avessero abbandonato i campi per l’officina, i cascinali per la città. E che comunque, a ben vedere, rimane pur sempre profonda ed imprescindibile parte di noi.
Altri libri
La croce di latta
Nel medesimo istante in cui, in una minuscola borgata della Val Chisone, viene alla luce una bambina non voluta, in un paese sui Peloritani un ragazzo riceve la chiamata alle armi, che lo spedisce sul fronte della Grande Guerra.
È l’inizio d’un racconto che si dipanerà lungo novant’anni, in un intreccio di vite e di generazioni, tra quotidianità e grandi passioni, amore e morte, cronaca e storia.
Buona fine e buon principio
Nell’ultima settimana della sua carriera il non sufficientemente performante ispettore di polizia Leonardo D’Aprile è in servizio quando, la notte di Natale, qualcuno dà fuoco a un poveraccio e al suo giaciglio di fortuna e alla sera il fiume restituisce il cadavere d’un uomo, noto nel mondo degli ultimi come il Professore, che scambiava libri per un tozzo di pane.
Molecole d'Acqua
In questa società fluida – in cui tutto è momentaneo, mutevole, ambiguo – condannata a inseguire due miraggi, velocità e successo individuale, noi siamo come molecole d’acqua in balia d’un oceano inquinato dai tensioattivi.
Per intrinseca natura ci leghiamo tra noi a formare una goccia e aderiamo alla superficie del luogo che ci accoglie: si chiama tensione superficiale.